WIP 2 - Visioni dell’anima

CONIUGI
I protagonisti vennero ritratti nella loro camera da letto. Sullo sfondo si vede uno specchio convesso che denota la ricchezza della coppia. La cornice dello specchio è decorata con le storie della Passione di Cristo; alla parete è appeso il rosario. Le Storie di Cristo e il rosario stanno ad indicare la fede dei due sposi.
I coniugi indossano vesti preziose: le loro immagini si riflettono di spalle nello specchio, che a sua volta ci rimanda anche la figura di altre due persone ferme sulla soglia. La coppia è rappresentata nel momento preciso in cui l’unione delle mani simboleggia l’unione delle vite: le figure che si riflettono nello specchio possono essere dunque comprese come i testimoni delle nozze.
Il cane accanto alla veste della donna rappresenta la fedeltà e così pure alla fedeltà rimanda l’unica candela accesa sul lampadario. Tuttavia, la scena non viene ambientata in un’ora notturna, ma di giorno: dunque la presenza della candela accesa ricorda la necessità che la fiamma della fedeltà tra due coniugi non venga mai spenta.
Gli zoccoli in basso a sinistra alludono alla sacralità del luogo e ricordano l’invito rivolto da Dio a Mosè di levarsi i sandali perché il suolo che stava calpestando era sacro.

BACI
Infatti, un pugnale si intravvede spuntare dal mantello, l’uomo ha il volto coperto come se fosse un cospiratore e il suo piede sinistro, appoggiato al gradino, è nella posizione di chi sta per partire.
Gli amanti spiccano grazie ai contorni ben disegnati e ai colori vivaci degli abiti. La passione è espressa dal corpo femminile che si inarca e dalle teste congiunte in cui non si distinguono le fisionomie. Lo sfondo è neutro e contribuisce a evidenziare i colori delle figure. È magistrale il contrasto fra i colori caldi dell’abbigliamento dell’uomo (il bruno del mantello e il rosso della calzamaglia) e i toni freddi e metallici dell’abito celeste della donna. La luce vivida che proviene da sinistra evidenzia gli effetti di chiaroscuro sui capelli e i colpi luminosi sulla veste preziosa della donna.

La coppia è immaginata al centro di un prato fiorito che ricorda l’hortus conclusus della tradizione medioevale, mentre la profusione dell’oro rimanda all’arte bizantina. Come le icone bizantine, anche in questo quadro il pittore ha reso evidenti solo i volti, le mani e i piedi. L’artista in questo modo riesce a restituire il senso dell’unione raggiunta dagli amanti, ma anche la loro individualità: egli infatti indica negli elementi geometrici inseriti nella veste di lui la mascolinità e in quelli concentrici della veste di lei la femminilità.

PASSEGGIATA
Sullo sfondo si scorge Vitebsk, il paese dove entrambi erano nati e in cui vivevano sino a quel momento. Inserendo la scena in una giornata piena di sole, il pittore ha voluto farci partecipi della semplice serenità dei due coniugi, attraverso gesti consueti come quello di condividere con la moglie una colazione sull’erba fiorita. Tuttavia sono proprio questa quotidianità e questa semplicità che ci parlano della profonda intimità degli sposi; essi non hanno necessità di servirsi di elementi esotici per godere del loro amore: basta ciò che la vita ogni giorno riserva.
Pur nella leggerezza che il volo della donna imprime al dipinto, sembra quasi di poter toccare la dolcezza che il pittore prova per Bella. L’amore è quella forza che dà all’uomo la possibilità di andare oltre gli schemi e le rappresentazioni e qui Chagall intende farci gustare la sua estasi violando le leggi della fisica, come quella della gravità.
WIP 4
La testimonianza di Joseph Ratzinger
Una delle mie zie a cui rendevamo visita frequentemente era madre di un bambino robusto, più giovane di me di qualche anno, affetto da sindrome di down. Nella semplicità della sua intelligenza «offuscata» egli suscitava una grande simpatia, e sua madre, che aveva perduto prematuramente una figlia, gli era molto affezionata. Nel 1941 le autorità del Terzo Reich esigettero il ricovero ospedaliero di questo bambino allo scopo di curarlo più adeguatamente. Nessun sospetto pesava allora sull’esistenza dell’operazione di eliminazione dei deficienti mentali, peraltro già iniziata. Poco tempo dopo giunse la notizia che il bambino era deceduto di polmonite e che il suo corpo era stato cremato. Da quel momento le notizie di questo genere si moltiplicarono. Nel villaggio dove abitavamo prima, rendevamo visita spesso ad una vedova che non aveva avuto figli e che si dimostrava felice di incontrare i vicini. La piccola proprietà ereditata dal padre le dava il giusto per vivere, ma essa si accontentava, pur manifestando qualche timore per l’avvenire. Più tardi avemmo modo di apprendere che la solitudine crescente in cui si trovava aveva progressivamente oscurato il suo spirito: la paura dell’avvenire era divenuta patologica a tal punto che non osava quasi neppure mangiare, temendo continuamente di non aver cibo da mettere sotto i denti. Venne allora classificata come malata mentale, ricoverata in ospedale e anche per essa giunse ben presto la notizia della morte per polmonite. Poco tempo dopo il medesimo fatto si ripeté di nuovo nel nostro villaggio: la piccola proprietà contigua alla nostra era affidata, fino a quel momento, alle cure di tre fratelli celibi, ai quali apparteneva. Venivano considerati degli infermi di mente, ma ciò nonostante erano in grado di occuparsi della loro casa e della proprietà. Anch’essi scomparvero e vennero condotti in un luogo di ricovero; poco dopo si apprese che erano morti. A quel punto non c’era più alcun dubbio che eravamo di fronte all’eliminazione sistematica di tutti coloro che erano considerati improduttivi.
(Joseph Ratzinger, «La grandeur de l’être humain c’est sa ressemblance avec Dieu», in Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica, Effatà Editrice, Cantalupa 2007)

WIP 4
Il dovere di cura nella storia
Se consultiamo codici babilonesi e geroglifici egizi possiamo imbatterci in figure di tipo religioso-sanitario che avevano il compito di combattere la malattia, ritenuta una conseguenza del comportamento amorale dell’individuo. Chi causava le malattie erano dèi e demoni, ma i veri responsabili erano gli stessi ammalati, che si erano resi colpevoli di qualche atto immorale. Anche presso i greci si pensava che solo l’uomo sano e bello potesse essere anche virtuoso. Così la malattia venne percepita come qualcosa di immorale e combattuta poiché le sue manifestazioni erano intese come segno delle sregolatezze dell’ammalato. L’infermo, dal canto suo, venne considerato incapace di qualsiasi autonomia decisionale, forza fisica e morale: è ciò che si chiama paternalismo medico.
Nel medioevo il medico divenne un laico illuminato investito di un ruolo sacerdotale, perché si occupava di curare il corpo delle persone.
Nel 1803, con il trattato Medical Ethics, Thomas Percival schematizzò in questo modo i tratti essenziali del medico: doveva vivere onestamente, non ledere alcuno, accordare a ciascuno il suo.
Il liberalismo produsse effetti anche sulla medicina: l’ammalato venne considerato progressivamente sempre più una persona adulta a cui devono essere comunicate informazioni sulla propria salute e le relative possibilità di cura. In possesso di queste indicazioni la persona può essere in grado di decidere in piena autonomia le cure più adatte.
WIP 4
Accanimento terapeutico
Una cura inefficace, inutile, non supportata da obiettivi raggiungibili è sempre sproporzionata e non giustificabile. Un trattamento inutile ed inefficace inoltre, è privo di valore terapeutico, non potendo essere finalizzato al bene del paziente. La gravosità dell’atto diagnostico-terapeutico e le eventuali sofferenze associate costituiscono elementi che possono condurre a veri e propri atteggiamenti di violenza terapeutica.
(R. Proietti, «Accanimento terapeutico», in: a cura di G. Cinà, E. Locci, C. Rocchetta, L.Sandrin, Dizionario di Teologia Pastorale Sanitaria, Edizioni Camilliane, Torino 1997)

Il paziente terminale
Secondo i Comitati etici, al paziente terminale devono essere assicurate cure palliative. Tuttavia definire chi è un paziente terminale è difficile poiché malattie che sino a pochi anni fa riducevano drasticamente le attese di vita e si risolvevano con la morte, oggi vedono una sopravvivenza di molti anni.
Inoltre le indicazioni mediche sono sempre del tutto generali perché non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo. Vi sono però tre tipologie di persone che fanno sorgere posizioni diverse in bioetica:
• Coma causato dalla compromissione dello stato di coscienza dovuta a ragioni metaboliche o cerebrali. L’ammalato ha gli occhi chiusi, non ha coscienza e gli stimoli esterni non lo risvegliano. Si tratta di un sintomo e non di una malattia che ha causato una riduzione funzionale del cervello. Il coma può essere reversibile anche dopo mesi. In questo caso vi è un recupero della coscienza e delle funzioni intellettive superiori (più o meno completo). Quando ciò non avviene si ha:
• Stato vegetativo persistente, caratterizzato da un paziente incosciente ad occhi aperti in cui si alternano veglia e sonno. Il paziente non è mai consapevole né di sé né dell’ambiente che lo circonda. Capo ed occhi possono ruotare spontaneamente verso gli oggetti, può essere presente la possibilità di emettere suoni e movimenti afinalistici di masticazione.
• Morte cerebrale. Il sostegno vitale deve essere mantenuto sino all’accertamento della morte e in seguito solo al fine di preservare gli organi destinati al trapianto.
La compromissione della qualità della vita quindi, anche nei casi-limite, non riduce la dignità della persona e le cure ordinarie devono essere sempre e comunque garantite. La loro soppressione sarebbe finalizzata a provocarne la morte, configurando una scelta eutanasica certamente non condivisibile in un’ottica di vita intesa come dono e, come tale, da tutelare dal concepimento sino al suo termine naturale.
(Enrico Larghero, «Dovere di cura ed accanimento terapeutico» in: Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica, Effatà Editrice, Cantalupa 2007 )
WIP 4
Scegliere di morire?
La trasformazione culturale degli ultimi decenni è resa ancora più evidente dall’esponenziale dilatazione delle umane aspettative di vita e di cura: l’uomo contemporaneo pretende dal progresso farmacologico la soluzione definitiva contro la morte nell’illogica speranza di raggiungere la sospirata eternità. Ma, in verità, la medicina oggi deve essere chiamata a rispettare la morte, omettendo atti di anticipazione o di accanimento terapeutico, e ciò perché la fine dell’esistenza non è affatto inscritta nell’ambito tecnico-scientifico, non è manipolabile, bensì il momento culminante della vita di una persona, giunta al termine della sua esperienza terrena.
(Alessandro Pertosa, Scelgo di morire? Eutanasia-accanimento terapeutico-eubosia, EDB, Bologna 2006)
La morte espropriata
L’eutanasia priva il malato terminale della sua morte, anticipandola ad un tempo che non è ancora il tempo della morte, mentre l’accanimento terapeutico lo priva della morte, perché essa viene ricacciata indietro in un tempo nel quale il malato terminale non sarebbe chiamato ad abitare. In entrambi i casi, si tratta di una morte espropriata, cioè non più appartenente (ovvero propria) al morente ma artificiosamente collocata in un tempo che non è quello di chi sta vivendo l’evento della morte.
(Cataldo Zuccaro, Il morire umano. Un invito alla teologia morale, Queriniana, Brescia 2002)

WIP 6
Il diritto di sciopero
Il diritto di sciopero nasce con il sorgere del conflitto industriale, in quel periodo immediatamente successivo alla Seconda rivoluzione industriale (metà del XIX secolo) nel quale più forte si manifesta la contrapposizione fra lavoratori e datori di lavoro. In un contesto di scarse o nulle tutele della prestazione lavorativa, lo sciopero emerge come l’unica arma in mano ai lavoratori per creare un rischio oggettivo ai proprietari dei mezzi di produzione, soprattutto in ordine a una sostenibile retribuzione o a orari di lavoro meno usuranti.
(da www.radiocittaperta.it)
La dottrina sociale riconosce la legittimità dello sciopero «quando appare lo strumento inevitabile, o quanto meno necessario, in vista di un vantaggio proporzionato», dopo che si sono rivelate inefficaci tutte le altre modalità di superamento dei conflitti. Lo sciopero, una delle conquiste più travagliate dell'associazionismo sindacale, può essere definito come il rifiuto collettivo e concertato, da parte dei lavoratori, di svolgere le loro prestazioni, allo scopo di ottenere, per mezzo della pressione così esercitata sui datori di lavoro, sullo Stato e sull’opinione pubblica, migliori condizioni di lavoro e della loro situazione sociale. Anche lo sciopero, per quanto si profili «come una specie di ultimatum», deve essere sempre un metodo pacifico di rivendicazione e di lotta per i propri diritti; esso diventa «moralmente inaccettabile allorché è accompagnato da violenze oppure gli si assegnano obiettivi non direttamente connessi con le condizioni di lavoro o in contrasto con il bene comune».
(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 304)
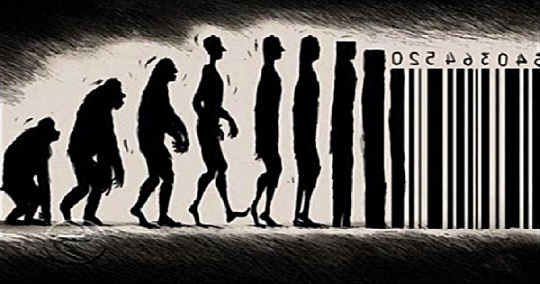
WIP 6
Devianza e mercato del consumo
Il fascino esercitato dal mercato è, al tempo stesso, un potente fattore di disparità sociale e di eguaglianza. Un’induzione al consumo (in misura sempre maggiore) può essere efficace solo se indiscriminata e indirizzata a chiunque sia disposto a lasciarsi influenzare. Ma le sollecitazioni del messaggio seduttivo trovano più ascolto che rispondenza. Chi non può soddisfare i desideri che esso accende assiste quotidianamente allo sfarzoso spettacolo di coloro che invece sono in grado di appagarli, ben sapendo, come vuole il costume in uso, che il consumo vistoso è il segno del successo, la via maestra verso la fama e l’approvazione sociale; e che il possesso e il godimento di alcuni beni e il potersi permettere certi stili di vita è la condizione necessaria della felicità, se non addirittura della dignità umana. Ma se il consumo è la misura di tutto questo, allora non c’è più limite ai nostri desideri; nessuna quantità di beni e di sensazioni eccitanti potrà mai procurare una soddisfazione simile a quella promessa un tempo dalla “capacità di raggiungere certi standard”, poiché non vi sono più parametri prestabiliti. Il traguardo finale si sposta sempre più avanti e gli obiettivi sono sempre uno o due passi più distanti man mano che si cerca di avvicinarsi ad essi. Tutti i record vengono continuamente superati e non sembra esservi più fine a ciò che un uomo può desiderare. Stupefatti e sconcertati apprendiamo che nelle nuove imprese privatizzate e “liberalizzate”, che un tempo erano pubbliche istituzioni sempre alla ricerca di capitali, gli attuali manager guadagnano stipendi vertiginosi, mentre quelli estromessi ricevono liquidazioni miliardarie per gli scarsi servizi resi. Da dovunque provenga, e qualunque sia il canale di comunicazione, il messaggio suona forte e chiaro: non esiste alcuno standard, se non quello di arraffare il più possibile, né alcuna regola, salvo l’imperativo di “giocare bene le proprie carte”. Ma non tutti i giochi sono corretti. Se l’unico obiettivo è vincere, chi ci ha rimesso cercherà di rifarsi utilizzando qualsiasi altra risorsa di cui può disporre.
(Zygmunt Bauman, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Edizioni Città aperta, 2004)

WIP 6
La convivenza in una società multietnica
La nostra è diventata una società multietnica perché la prospettiva di una vita migliore e di un lavoro decentemente retribuito ha indotto molte persone a lasciare la propria terra d’origine e a trasferirsi nel nostro paese. Pertanto ovunque, nelle scuole, negli ambienti pubblici e lavorativi, per le strade, quotidianamente ci confrontiamo con persone che appartengono a realtà diverse dalla nostra e che vantano tradizioni, usi e costumi a noi sconosciuti e praticano altre religioni.
La convivenza multietnica dovrebbe essere legata al principio di tolleranza e di rispetto reciproco. Purtroppo ciò spesso non trova riscontro nella realtà, in cui si rilevano situazioni drammatiche di grande disagio, di disadattamento poiché queste persone non riescono a trovare un posto di lavoro dignitoso, che dia loro la possibilità di soddisfare i bisogni primari. Molti vengono ingaggiati solo per alcuni periodi dell’anno per espletare le operazioni di raccolta nei campi oppure per mansioni precarie e poco qualificate. Spesso la retribuzione è irrisoria rispetto alla mole di lavoro svolta.
Spesso sui giornali vengono riportate delle notizie che evidenziano che queste persone non sono integrate nella nostra società e sono oggetto di episodi di intolleranza e razzismo. Non penso che si possa parlare di vera xenofobia, ma ritengo che questi comportamenti nascano dalla difficoltà di confrontarsi con culture diverse, dalla diffidenza reciproca e dalla paura di vedere scemare il proprio benessere economico e le proprie sicurezze.
Capita talvolta di assistere a situazioni che fanno riflettere; per esempio, tempo fa ho visto una vecchietta che, fermata da due zingari, è stata trattata in malo modo perché non aveva elargito la somma richiesta. Questo comportamento mi è parso strano perché vicino alla parrocchia, da me frequentata, si ferma spesso una ragazza rumena che è sempre gentile, discreta e non invadente. Pertanto ritengo che l’integrazione di alcuni immigrati è difficile anche per il retaggio culturale di alcuni di loro. Penso che mostrando più tolleranza e rispetto reciproco si possa realizzare una convivenza multietnica che sia vantaggiosa per tutti, in cui le diversità culturali delle parti siano un incentivo all’arricchimento del proprio bagaglio culturale.
(alexuccia1999, 15 gennaio 2012, da Repubblica@Scuola - Studente reporter)

WIP 6
Le moderne forme di schiavitù
La schiavitù è una piaga che accompagna l’uomo sin dal suo sorgere e che ancora ai nostri giorni tiene sottomesse moltissime persone.
• La schiavitù per debiti è oggi la forma più diffusa ed è causata dal prestito ad usura, che si trova soprattutto in ambito rurale dei paesi del terzo mondo. Questo sistema prevede che le famiglie bisognose, obbligate a richiedere prestiti ai ricchi proprietari terrieri, siano in seguito costrette a restituire lavoro gratuito in cambio del denaro ricevuto. Se chi ha contratto il debito non potrà renderlo direttamente in ore-lavoro, la restituzione sarà sanata da uno o più dei membri della famiglia. Sovente questi schiavi sono bambini, costretti a lavorare a vita a causa dei tassi elevati richiesti dagli strozzini per estinguere il debito. Quando la famiglia non riesce a pagare il debito in una generazione, la condizione di schiavitù viene tramandata di padre in figlio. Oggi ci sono 20 milioni di schiavi per debiti nelle piantagioni in Africa, nei Caraibi e nel sud-est asiatico.
• La servitù della gleba non è un’istituzione cancellata dalla faccia delle terra. Ancora oggi quest’uso tradizionale, che ha le caratteristiche proprie di una vera piaga sociale, lega i braccianti ai loro proprietari terrieri costringendo individui, famiglie o interi gruppi sociali a lavorare senza salario. Ad essi infatti è concesso di coltivare la terra solo a patto di lavorare per i grandi latifondisti. Il lavoro svolto non è retribuito con denaro, ma in buoni-acquisto, che possono essere spesi solo in spacci che appartengono agli stessi proprietari.
• Il lavoro coatto colpisce soprattutto gli individui più deboli o svantaggiati o i rifugiati, gli appartenenti a minoranze etniche, le donne e i bambini reclutati illegalmente da governi, movimenti politici o da privati e costretti a privarsi della libertà e della dignità, lavorando sotto la costante minaccia di violenze. In Myanmar l’esercito costringe gli appartenenti a minoranze etniche a lavorare gratuitamente la terra e a ricostruire strade. La barbarie è giunta a costringere le persone a lavorare per l’esercito facendole entrare nei campi minati e usandole come “detector umani” di mine.
Secondo le stime delle Nazioni Unite, ogni anno sono circa 4 milioni gli individui venduti ricorrendo alla forza o all’inganno, al fine di sfruttare il loro lavoro, detenendoli nella condizione di schiavitù. La schiavitù non mostra soltanto il volto dello sfruttamento della forza-lavoro nei campi, nell’edilizia e nella costruzione di infrastrutture. Il volto più ignominioso della piaga si rivela nell’attività stimata più redditizia dai trafficanti di persone, ovvero la prostituzione e la pornografia. Ciò avviene soprattutto in Asia, in Africa e in America Latina: secondo l’Unicef, sono almeno un milione le bambine e ragazze costrette a prostituirsi nella sola Asia.

WIP 6
La pena di morte
La pena di morte consiste nell’esecuzione di un detenuto che, nei Paesi in cui essa è ancora legale, viene comminata da un tribunale. Normalmente i reati che gli Stati intendono punire in questo modo sono particolarmente gravi ed efferati. Tuttavia in molti Paesi, come la Cina, il Pakistan, l’Arabia Saudita e molti Stati in cui vige la shari’a, si può essere condannati a morte anche per offese alla religione o al pudore.
L’inutilità e la grave violazione della dignità della persona implicita in questa pena hanno indotto molti Paesi ad abolire la pena di morte. Tuttavia sono ancora molti gli Stati che mantengono la pena di morte nei loro ordinamenti giudiziari.
Il Dio della Bibbia si rivela all’uomo progressivamente e lo fa a partire dalla situazione morale, sociale e storica dell’uomo concreto conosciuto dagli autori sacri. Questa realtà dovrebbe mitigare in noi lo stupore nel momento in cui, scorrendo le pagine della Bibbia, leggiamo che Dio stesso stabilisce la pena capitale. Noi che abbiamo perso il senso del rispetto del giorno festivo non condanneremmo nessuno a morte per aver infranto il riposo del sabato! Tuttavia, la Bibbia deve essere considerato un libro rivelato nel suo complesso. Ciò che in alcune pagine ci può sembrare oscuro acquista senso alla luce di altre. Così, sempre nell’Antico Testamento (Genesi 2,12-15), troviamo passi in cui la divinità condanna la vendetta umana, minacciando punizioni peggiori (“sette volte” e “settanta volte sette”) a chi si fosse vendicato della morte di Abele uccidendo Caino.
La vera svolta tuttavia avviene nel Nuovo Testamento, dove Gesù richiama più volte al perdono e condanna l’episodio della lapidazione della donna adultera: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» (Giovanni 8,7).
Nella storia della Chiesa pensatori importanti, come Agostino e Tommaso d’Aquino, sostennero la liceità della pena di morte. Essi motivavano la sua opportunità partendo dal principio che era assolutamente e primariamente importante conservare il bene comune. Tommaso riteneva invece che così come è lecito, anzi doveroso, estirpare una parte malata al fine di salvare tutto il corpo, allo stesso modo quando una persona è un pericolo per la comunità o si comporta in modo tale da essere causa di corruzione per gli altri, deve essere eliminata al fine di garantire la salvezza della comunità (Summa Theologiae II-II, q. 29, 37-42). Secondo Tommaso, tuttavia, la pena doveva essere inflitta a chi si era reso colpevole di gravissimi delitti.
Bernardo di Chiaravalle pensava che, durante le crociate, il cristiano potesse uccidere i nemici pagani, perché uccidendoli avrebbe eliminato il “male che era in loro”. Solo nel 1969 lo Stato pontificio ha abolito la pena di morte, che in ogni caso non aveva da molto tempo applicato.
La riflessione sul tema della pena di morte venne stimolata nel 1764 dalla pubblicazione di un libro di Cesare Beccaria dal titolo Dei delitti e delle pene. In questo testo, l’autore voleva riflettere sul sistema penale vigente, finendo per collocarsi nettamente contro la pena di morte. Secondo il suo ragionamento, lo Stato che applicava questa pena con l’intenzione di punire un delitto, in realtà privando della vita il reo non si mostrava molto migliore di colui che voleva punire perché ne commetteva uno a sua volta.
Il Catechismo della Chiesa cattolica afferma che oggi lo Stato possiede molti mezzi per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo chi l’ha commesso. Tutte le punizioni devono avere come fine la redenzione del reo, perciò anche le pene comminate non possono togliere all’uomo la possibilità di riscattarsi, eventualità ovviamente esclusa dalla pena di morte. La riflessione dei teologi e dei pontefici in questi ultimi anni ha insistito sul diritto alla vita.
